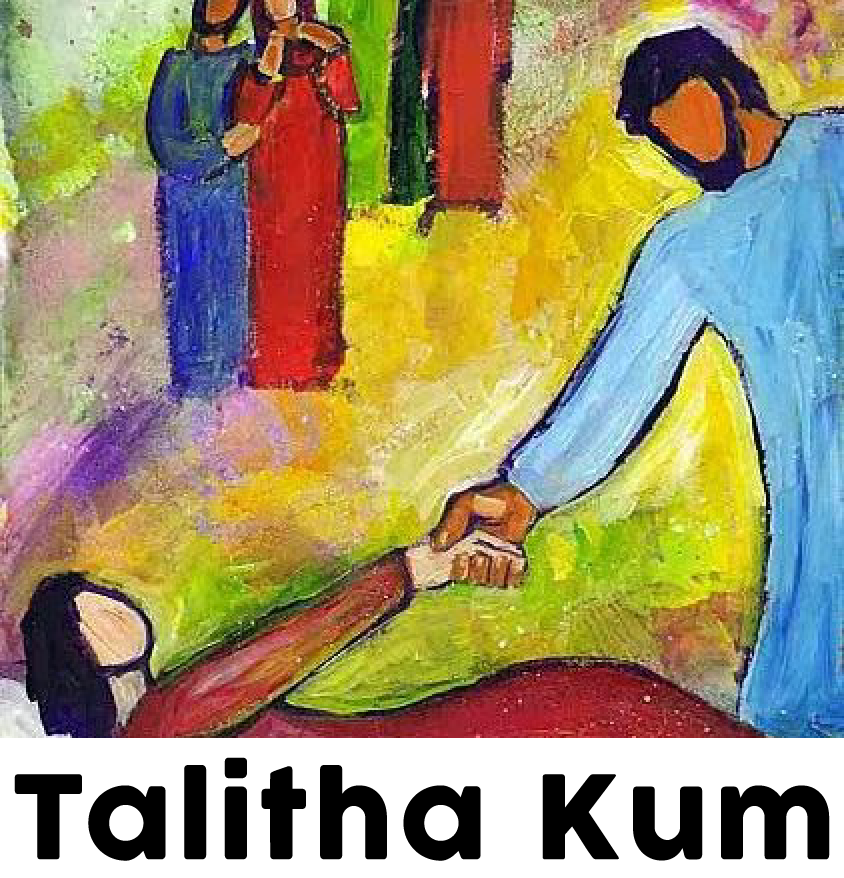La lettera apostolica “Patris corde”

Giuseppe ben Yacob, di Betlemme, mani indurite dal lavoro e cuore intenerito dall’amore e dai sogni; ascoltatore silenzioso del brusio degli angeli attraverso l’umile via dei sogni; sposo che non rivendica mai la primogenitura del sì di Maria, detto a lui prima ancora che a Dio, è per il piccolo Gesù l’esperienza fondativa di cosa significhi un cuore di padre.
La lettera apostolica “Patris corde”, con cui Francesco istituisce l’anno di san Giuseppe, ne disegna un ritratto bello come una sorpresa, vivo come una ventata d’aria fresca.
Il mondo ha bisogno di padri e “Giuseppe è sulla terra l’ombra del Padre celeste” (PC). Da chi ha imparato Gesù ad andare oltre la legge antica, a mettere la persona prima delle regole, se non ascoltando da Giuseppe il racconto di come si sono conosciuti lui e Maria e del dramma vissuto (voleva ripudiarla in segreto...)? Ai figli piace sentire queste storie.
Dove ha capito il piccolo Gesù che l’amore viene prima di tutto, che è sempre un po’ fuorilegge?
Dove ha imparato a scegliere il termine affettuoso di “abbà” per dire l’Altissimo, quella parola da bambini, un balbettio nel dialetto del cuore, se non in quell’uomo dagli occhi e dal cuore profondi?
Nel suo volto e nel suo vigore Gesù ha letto la parabola della combattiva tenerezza di Dio, e ne è diventato il racconto.
Giuseppe, il giusto, nel vangelo di Matteo sogna quattro volte: l’uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio; ne vive, perché “la vita trae radici dal sogno” (Turoldo); non si accontenta del mondo così com’è. Mentre noi viviamo in una società cui sono stati scippati i sogni, che punta più a mantenere l’esistente che a generare futuro possibile.
“Senza risveglio – ha detto con molta intelligenza Roberto Benigni – non si può sognare”. Giuseppe è risvegliato dai sogni e agisce, nonostante che ogni volta si tratti di un annunzio parziale, di una profezia breve, di luce appena per il primo passo.
Sono sogni di parole. Ed è quello che è concesso a tutti e a ciascuno, a chi si lascia abitare dal Vangelo con il suo sogno di cieli nuovi e terra nuova.
Giuseppe accoglie Maria, ama quella ragazza al punto di sognarsela anche di notte; l’ama più della propria discendenza, più della propria paternità fisica.
Il suo non è un rassegnato, ma un virile e straordinario “sì” alla realtà che non ha deciso lui. “La vita spirituale che Giuseppe, sposo nell’accoglienza, ci mostra non è una via che spiega, ma una via che accoglie” (Patris Corde), nella fragilità e in profonda tenerezza.
In un mondo in cui la violenza psicologica, verbale e fisica sulla donna è evidente, Giuseppe si presenta come figura di uomo rispettoso, delicato, che si decide per la reputazione, la dignità e la vita di Maria.
Secondo sogno: prendi il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. E Giuseppe si alza, stringe a sé la sua famiglia e si mette in cammino. Tre azioni da scolpire nel diario di casa: seguire un sogno, avviare un cammino, custodire. Tre verbi decisivi per le sorti di ogni famiglia, e per le sorti del mondo.
Mettersi in cammino, è la seconda azione. Non stare fermi, anche se Dio offre davvero poco, solo la direzione verso cui fuggire; ed è allora che subentrano il coraggio e l’intelligenza, la creatività e la tenacia di Giuseppe. Tocca a lui studiare itinerari e riposi, misurare fatica e forze. Il Signore non offre un prontuario di regole, lui accende obbiettivi, poi ti affida alla tua libertà e alla tua intelligenza.
Il terzo verbo è custodire, stringere a sé, proteggere. Due ragazzi innamorati e un neonato, quasi niente, eppure le sorti del mondo si decidono dentro questa famiglia di profughi e di profeti, protettrice del popolo innumerevole dei migranti e degli innamorati.
“Erode è morto, ritorna in terra d’Israele”. Di nuovo in cammino, vero padre, anche se nascosto e in seconda linea: “tutte le volte che qualcuno si assume la responsabilità della vita di un altro, in un certo senso esercita la paternità nei suoi confronti” (Patris Corde).
Un ultimo sogno gli indica la Galilea. A Nazaret Giuseppe scava nel suo cuore e spalanca spazi a quella donna e a quel bambino, che porta in sé un inedito che può essere rivelato solo con l’aiuto di un padre che rispetta la sua libertà.
Essere padri significa introdurre il figlio all’esperienza della vita. Non trattenerlo, non imprigionarlo, ma renderlo capace di scelte, di libertà, di partenze. Donargli grandi ali.
Così ha fatto Giuseppe, concreto e sognatore, sposo nell’accoglienza tenera, padre amato nel nascosto, quotidiano coraggio creativo.
Ermes Ronchi