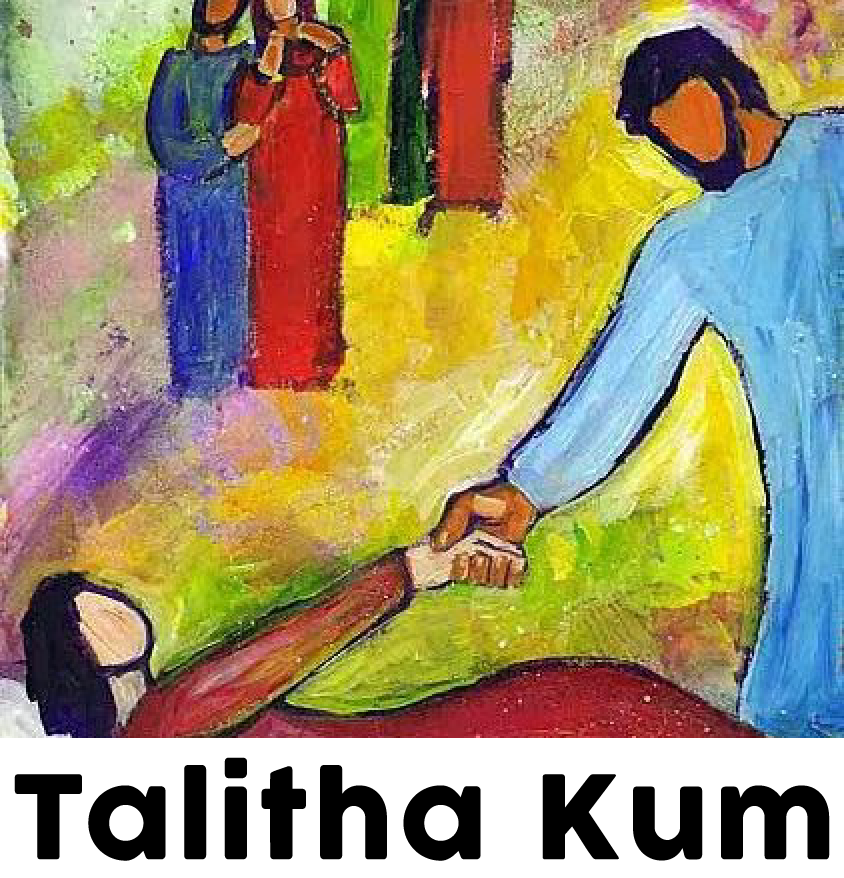Intervista a fra Ermes Ronchi per la Voce dei Berici
«Inciampare in una stella, come i re magi e poi smarrirsi nel pulviscolo magico del deserto».
È l’augurio che ci fa padre Ermes Ronchi per questo nuovo anno appena
iniziato. Incontriamo il frate dell’Ordine dei Servi di Santa Maria al
convento di S. Maria del Cengio a Isola Vicentina per farci aiutare a
scrutare l’anno che sta iniziando e lui, richiamando un verso di frate
Davide Montagna ci rimanda alla stella che «può essere una persona, un
libro, una poesia, un amore, gli occhi di un bambino. Una stella per
avere tanta luce quanto ne basta al primo passo. E ce ne sono tante
stelle in giro. Camminiamo su gioielli – ci dice – senza accorgercene. E
poi la luce si rinnova a ogni passo perché non
siamo soli. Con noi c’è Dio».
Ma partiamo da questo incredibile Ventiventi. P. Ermes mi dica
tre immagini che sintetizzano per lei l’anno che si è appena concluso.
«Papa Francesco da solo in piazza San Pietro venerdì 27 marzo, in quella
piazza deserta, sotto la pioggia, che va via a tu per tu con il
crocifisso per pregare per il mondo. Era solo, ma c’eravamo tutti. A me è
sembrato quello, in un certo senso, un punto zero della Storia.
La seconda è la bellezza degli occhi delle persone dietro le mascherine.
Ci si può riconoscere con gli occhi, ci si può parlare con gli occhi,
ci si può abbracciare con gli occhi.
L’ultima è da dire sottovoce pensando a chi ha molto sofferto. La dico
con un verso di una poesia di Mariangela Gualtieri: “C’è dell’oro in
questo tempo strano”. E allora a me piace andare alla ricerca di qualche
pepita».
Ci confida qualcuna delle pepite che ha trovato?
«Prima di tutto il linguaggio della cura. Noi siamo ciò di cui ci
prendiamo cura. Poi il non implodere dentro alle cose. Rischiamo di
implodere per l’accumulo di cose e invece, come ci dice il profeta
Isaia, dobbiamo alzare il capo e guardare. È questo un tempo che ha
delle crepe, ma è attraverso le crepe che entra la luce. Si deve parlare
attraverso le crepe di questo tempo desolante e desolato».
A livello comunitario questi dodici mesi che cosa ci dicono?
«Ci dicono che la salute dei più forti dipende dalla salute dei più
deboli, cioè dalla cura dell’anello debole. È un rovesciamento
paradossale. Abbiamo riscoperto la vita partendo dalla fragilità, non
dall’esaltazione del vivere per il vivere e basta, ma dalla riscoperta
di cosa è vita e di cosa non lo è. Questa attenzione me la rivelano
soprattutto i più deboli. Proteggendo l’anello debole proteggiamo tutti. Questo è un grande insegnamento».
Secondo lei lo abbiamo capito?
«Io credo di sì. Nessuno si salva da solo. Nessuno è forte da solo. Noi
siamo più forti se proteggiamo i deboli. Questo vuol dire rimettere la
persona al centro, qualsiasi persona».
Lei ha avuto paura del virus?
«No. Non ho avuto paura. Ho cercato di tradurre la paura, che comunque
fa capolino, in prudenza e in cura. Abbiamo sentito la vita assediata
dal virus, assediata ma non espugnata. Non ho paura per il covid. Ho
paura per ciò che ha causato questa pandemia.
Questo sì mi fa paura: l’aggressione dell’uomo all’ecosistema. Tutti i
virus sono di origine animale. Noi abbiamo bruciato la casa degli
animali, l’abbiamo avvelenata. Quella è l’autostrada attraverso la quale
i virus arrivano fino a noi. Mi fa paura questo atteggiamento
suicidario dell’uomo che persevera ad aggredire la terra. Mi sembra che
possiamo fare un comandamento che non c’è: “Ama la terra, come ami te
stesso. Amala come l’ama Dio».
La pandemia come ci ha cambiati?
«Penso che non è un virus che cambia il cuore delle persone. Il covid
può venire e andarsene senza che questo davvero ci cambi. I veri
cambiamenti non sono indotti da un fattore esterno. I veri cambiamenti
sono quelli che escono dall’anima. Neanche la paura ci cambia. La paura
paralizza, non libera dal male che c’è in noi. La vita non avanza per
divieti o Dpcm. Solo una passione positiva, la cura, un desiderio fanno
avanzare la vita. La vita avanza per innamoramenti. Affrettiamoci ad amare. Le persone se ne vanno così in fretta. Non perdiamo tempo».
Tutto questo porterà a dei cambiamenti strutturali?
«Io penso di sì. Immaginare di chiudersi nella propria regione, nella
propria provincia, nel proprio comune, nella propria camera per trovare
la salvezza in queste situazioni in cui il mondo è sottosopra e brucia è
come essere in una nave che affonda e chiudersi nella propria cabina
pensando di salvarsi: se la nave affonda, vai sotto anche tu. Siamo
tutti sulla stessa barca. Questa percezione c’è, come sentimento
strutturale. E infatti non si è mai visto tanto denaro promesso
dall’Europa come per questo Recovery plan. In questo c’è una strutturale
crescita della corresponsabilità. Per questo sono fiducioso. Questa è
una delle cose che segnerà il futuro. Quanto è accaduto porterà alla
percezione che tutto si tiene, tutto è correlato. Non possiamo vivere
sani in un mondo malato. Questa è una
percezione diffusa e determinante per il futuro. Noi che ci credevamo i
signori del creato abbiamo scoperto che dobbiamo stringere i fili
dell’empatia e della solidarietà»
La chiesa in questo che ruolo può avere?
«Questo tempo è l’occasione per fare un balzo indietro di duemila anni e
riscoprire la domus ecclesiae, cioè la chiesa nella casa. Fare un gesto
religioso insieme, attorno alla tavola che è il primo altare. Il
cristianesimo comincia nella casa non nella chiesa. Bisogna riscoprire
questo. Perché le parrocchie non danno questo input preciso? Lo Spirito
Santo non ti spinge ad andare in chiesa, ma a diventare chiesa. Gli ebrei hanno salvato la loro religione con la liturgia domestica».
Su cosa deve puntare la Chiesa?
«I due vettori per il futuro della chiesa sono la Parola di Dio e la
carità. Il terzo vettore che io vedo è la contemplazione, cioè la
capacità di fermarsi, di inginocchiarsi davanti alle cose, di scoprire
la bellezza delle cose, di stare a tu per tu con Dio. Il cristiano del
futuro o sarà un mistico o non sarà. O sarà un uomo che spezza il pane o
non sarà».
E ciascuno di noi come deve affrontare il futuro prossimo?
«”Affrettiamoci ad amare” direbbe il poeta polacco Jan Twardowski».